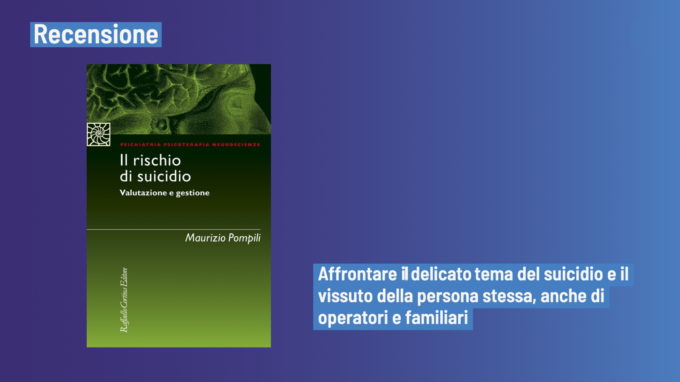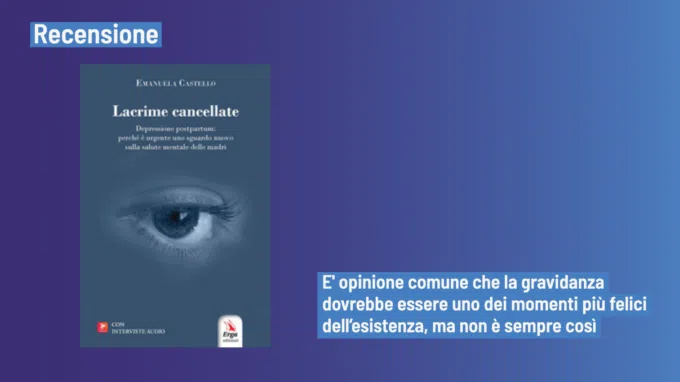Il testo “Il rischio di suicidio. Valutazione e gestione” offre una panoramica dettagliata di concetti e problematiche inerenti al tema del rischio suicidio e della possibilità di prevenzione, tenendo conto dei riferimenti presenti nella letteratura internazionale e clinica.
Si evince che, per la complessità dei temi trattati, il manuale risulta essere una motivazione per operatori e per professionisti a fornire il loro contributo continuo e la condivisione di esperienze e riflessioni che possano arricchire di informazioni preziose, per evitare di cadere in visioni pericolosamente riduzionistiche ed inesatte. Si aggiunga l’importante consapevolezza che i concetti riportati non possano mai essere completamente esaustivi, data la moltitudine di fattori presenti e l’interazione di variabili anche inattese, che possono scatenare una risposta così lontana da quel principio di sopravvivenza della specie che caratterizza l’essere umano e non solo. Un dato è sicuramente certo: colui che tenta un gesto così estremo si ritrova a considerare che esso stesso sia l’unica scelta rimasta, per contrastare un dolore insormontabile ed insopportabile. Il tempo vissuto sembra arrestarsi in un qui ed ora che contraria ogni elan vital, incastrato in pensieri negativi e in una condizione di sofferenza tale da far perdere il controllo. Condizione che va rispettata e affrontata con delicatezza, cercando di non rimanerne né impigliati, né condizionati da subdoli pregiudizi, spesso inconsapevoli, che possono condizionare l’intervento di ogni operatore che ha a che fare con tali dinamiche.
Nel primo capitolo il Prof. Pompili mette in evidenza il carattere multidisciplinare del tema del suicidio, in tutta la sua cruda tragicità, con una costante attenzione all’aspetto emotivo intrinseco, la guida per ogni esperienza mentale e fisica. In effetti l’emozione, dal latino ex movere, risulta correlarsi ad una spinta, ad un movimento che permette ad ogni singolo soggetto di posizionarsi nel mondo secondo le sue priorità, secondo quanto c’è di rilevante nella sua esperienza; la tonalità emotiva risulta la bussola individuale per direzionarsi nella propria esistenza, causa, essa stessa, in condizioni di sofferenza estrema, di gesti altrettanto estremi. Gli approcci sono sicuramente molteplici, da quello filosofico-esistenziale, a quello teologico, letterario, demografico, sociologico e socioculturale, fino a quello interpersonale, biologico e psicologico, più propriamente definito dal Prof. Pompili Mentalistico. In effetti, l’individuo si ritrova in uno stato perturbante che può degenerare in disperazione, intesa non solo come mancanza di speranza, ma anche e soprattutto di presenza di un dubbio, di quella incapacità decisionale che può innescare la convinzione che non ci possa essere una via di uscita. Kierkegaard parla di scheggia nelle carni, un’incapacità di ridurre la vita ad una scelta, che, in casi di fragilità estrema, può provocare quello strappo all’esistenza, come tentativo di placare un dolore incarnato, testimonianza di un rifiuto della propria essenza. E, non ultimo, l’approccio medico psichiatrico che, se da un lato ha permesso un’indagine accurata di terapie farmacologiche appropriate, dall’altro, però, rischia di concentrarsi sulla rilevanza di un disturbo o di una diagnosi e di considerare il gesto suicidario come una conseguenza. Nel corso della storia il suicidio è stato oggetto di stigma: in passato il suicida veniva considerato come colpevole e “condannato” a non avere un rito funebre e alla confisca di tutto il suo patrimonio. Tra il 1600 e il 1800 si parlava di non compost mentis, ossia di folle e di felo de se, ossia di autore di un crimine contro sé stesso. Nonostante l’importante processo di cambiamento avvenuto negli anni, sembra che tale impostazione abbia condizionato fortemente il pensiero moderno, in cui ancora risultano presenti, in alcuni contesti, precomprensioni che, a loro volta, condizionano l’approccio al fenomeno suicidario. In ogni caso, oggi il tema è osservato più da un punto di vista quantitativo che qualitativo, ossia il disturbo mentale, non ha un’importanza esclusiva; da qui ne deriva la necessità di comprendere lo stato di sofferenza, più che il tentativo di spiegarlo. Un approccio fenomenologico che porta ad interrogarsi non tanto o non solo sul cosa ha un soggetto, ma soprattutto sul come vive il proprio disagio. Il suicidio non è direttamente correlato al vizio di mente, ma alla difficoltà della stessa di “svolgere il suo ruolo auto organizzativo ed emergente”.